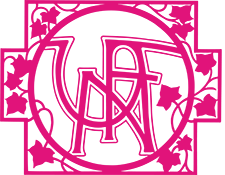Biologica o naturale è la capacità delle donne di fare maturare degli ovuli, di condurre a taermine una gravidanza iniziata, non il numero di figli messi al mondo per secoli. Tra ovulo e figlio, tra la capacità di procreare e il fatto di procreare stanno i rapporti tra i sessi. Tra la capacità di procreare e la procreazione attuata c’è la storia dei rapporti di riproduzione, dell’organizzazione sociale della riproduzione, in larga parte della riproduzione come sfruttamento.
Nel libro Le dita tagliate (Ediesse, 2014) Paola Tabet, etnologa, esamina la riproduzione come terreno fondamentale dei rapporti sociali tra i sessi a partire dai dati sulla gestione del corpo riproduttore e sugli agenti che intervengono nei diversi momenti della sequenza o processo riproduttivo.
L’analisi parte dal considerare le specificità biologiche della nostra specie in cui la femmina non ha l’estro. La pulsione sessuale non è collegata alla procreazione per via ormonale, quindi non c’è collegamento tra desiderio sessuale e periodo fertile, ed il momento di fertilità non è visibile all’esterno. Dal punto di vista etnografico, secondo Paola Tabet, il matrimonio è stata la soluzione più diffusa all’interno della specie per ovviare alla difficoltà di individuare il periodo fertile. Ne è derivato un sistema coercitivo basato sulla domesticazione della sessualità femminile.
Il problema allora è questo: se le donne non sono legate da condizionamenti ormonali alla riproduzione, se la biologia non costringe le donne alla procreazione (e in più la loro sessualità è tendenzialmente polimorfa e non vincolata all’ipoteca riproduttiva), come si è ottenuta la forte specializzazione riproduttiva della sessualità femminile? Come si assicura la coincidenza tra momento di ovulazione e accoppiamento visto che la pulsione sessuale non è sincronizzata su questo momento e che esso non è individuabile con sicurezza? […] la probabilità massima di successo o, in altri termini, la copertura più efficace delle possibilità di fecondazione è data dalla regolarità e frequenza dell’esposizione al coito. […] Il matrimonio sembra essere l’esposizione che, pur con tutte le differenze che presenta nelle varie società, garantisce questa copertura delle possibilità di fecondazione. E’ cioè l’istituzione che assicura un’esposizione regolare delle donne al coito e dunque un’esposizione permanente al rischio di gravidanza. […] Esposizione al rischio nell’accezione precisa di una esposizione istituzionalizzata.
Un insieme complesso di pressioni sociali e psichiche, di costrizioni materiali, di violenze fisiche socialmente ammesse, di interventi psico-fisici sulla sessualità femminile, consentono al matrimonio di realizzare la funzione di istituzione cardine dell’imposizione/controllo della riproduzione. […]
La domesticazione della sessualità femminile o, il che è lo stesso, l’addomesticamento delle donne alla riproduzione, è operazione lenta e continua.
L’etrnologa analizza una serie di casi in cui si rende manifesto l’insieme complesso di pressioni sociali e psichiche, di violenza fisiche socialmente ammesse, di interventi psico-fisici sulla sessualità femminile che consentono al matrimonio di realizzare la funzione di istituzione cardine dell’imposizione/controllo della riproduzione.
La divisione tra categorie di donne è uno degli effetti di questo sistema di organizzazione della riproduzione, a partire dalla riproduzione come lavoro.
Ma quello della riproduzione non è l’unico capitolo in cui si articola il libro.
La prima parte, infatti, è dedicata all’analisi della prostituzione secondo la prospettiva del continuum nello scambio sessuo-economico. Dal dono alla tariffa non ci sarebbero salti, ma solo differenti gradazioni della stessa condizione, se la società è organizzata in modo tale che le donne non abbiamo le stesse opportunità di accesso alle risorse che hanno gli uomini. L’etnologia sostiene questa tesi attraverso una vasta serie di fatti raccolti nello spazio e nelle tempo.
Nella terza parte l’autrice si occupa di un settore trascurato negli studi sulla divisione sessuale del lavoro e cioè gli strumenti e lo fa a partire dalle società preindustriali tecnologicamente più semplici. Da uno di questi casi è tratto il titolo del libro, le dita tagliate. Tra i Dugum Dani della Nuova Guinea alle bambine fra i tre e i sei anni sono mozzate alcune dite della mano nell’ambito di rituali funebri per un loro parente morto. Il taglio è fatto in modo da non compromettere la loro possibilità di lavorare, tuttavia rimangono loro precluse attività che richiedono l’uso delle dieci dita, come cacciare con arco e frecce o maneggiare asce e bastoni da scavo. Lavori da uomo, nota la Tabet, in una grande varietà di culture. Che si chiede se
Possiamo dunque metaforicamente dire che tutte le donne hanno le dita tagliate?
La domanda è legittima alla luce di parecchi indicatori che le organizzazioni internazionali e gli Stati vanno raccogliendo da una quarantina d’anni almeno. Indicatori sull’accesso alle risorse, all’istruzione, indicatori sulla salute sessuale e riproduttiva, indicatori sul giro d’affari della prostituzione. L’appello non è certo al vittimismo, quanto alla presa di coscienza:
Come gli operai di Nîmes ai quali Flora Tristan nel 1844 non riusciva a far «capire cosa significasse costruire la classe operaia», e che le dicevano: «Allora bisogna bene che ci siano i ricchi sennò come farebbero a vivere i poveri?», così le donne per vivere non possono fare a meno dell’«aiuto» degli uomini. Il cerchio di violenza e sfruttamento, di soppressione intellettuale e fisica delle donne si chiude con questa beffa, con questa particolare amara turlupinatura specifica ai rapporti di genere.
Le dita tagliate
di Paola Tabet, Ediesse, 2014
320 p., 15€