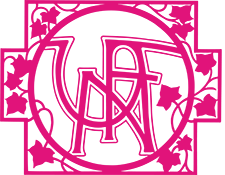Il bottonificio Binda a Milano: un’esperienza di ricerca didattica e di laboratorio con le fonti a scuola
di Concetta Brigadeci**
L’esperienza che qui racconto è frutto del caso, della tenacia mia e dei miei studenti, della curiosità che ha saputo oltrepassare tutti gli ostacoli di tipo istituzionale che si sono frapposti, compreso il divieto di uscire dalla scuola al pomeriggio e fuori dell’orario scolastico, senza il permesso dei genitori. Il caso sicuramente ha avuto un ruolo decisivo, perché trovare l’archivio cartaceo e dei prodotti del Bottonificio Binda, di cui nessuno aveva notizia, non è cosa da poco.
Insegno italiano e storia all’Istituto professionale per il turismo “L. V. Bertarelli”, frequentato da studenti con un forte disagio scolastico, spesso reduci da altre scuole, o che ripetono la stessa classe per più anni. A ciò si aggiunge un retroterra sociale, etnico e geografico difficile e variegato: arrivano in corso di Porta Romana, dove è situata la scuola, studenti immigrati da altre città d’Italia o da paesi del Terzo e Quarto Mondo, studenti provenienti dalla provincia o dall’hinterland milanese, studenti che abitano in zona. Tuttavia il loro atteggiamento nei confronti delle discipline- materie proposte dagli insegnanti li unifica, li affratella, in qualche modo. Si riscontra in loro uno stare passivo in classe, fatto di un senso di attesa che accada qualcosa d’indeterminato, in cui la loro soggettività non è assolutamente coinvolta: spaesamento nei confronti di saperi che pare non li riguardino. E, ogni volta, a noi insegnanti il ricondurli al lavoro e allo studio sembra una deportazione in territori sconosciuti in cui la loro identità, già così fragile, scompare, si frantuma. Da qui il loro disagio nei confronti di uno studio che non sa toccare le corde più sotterranee e soggettive, le uniche che possono stimolare interesse e produrre risultati concreti.
La mia collocazione culturale e sessuale di donna interessata alla ricerca e alla didattica della storia coltivate in ambiti diversi, dall’ISMEC (già ISRMO) alla Società Italiana delle Storiche, mi ha consegnato uno sguardo attento alla Storia delle donne o di genere che tuttavia in classe non volevo giustapporre come un medaglione alla storia generale. Essa mi ha tramandato un sapere che si fonda sull’esperienza di ognuno, discente e docente, ed in cui la soggettività individuale e la relazione reciproca sono messe continuamente in gioco e diventano pratiche didattiche e conoscenza organizzata dentro processi storici collettivi[i]. La parola data e ricevuta, l’ascolto reciproco, il porsi come un soggetto interrogante di fronte a problemi non ancora risolti e non sempre definitivamente certi, sono per me le modalità di base per creare una comunità di apprendimento /insegnamento e per iniziare un lavoro con gli studenti. Il presupposto da cui sono partita è la consapevolezza, comune a me e agli studenti, di sapere di non sapere, l’unico elemento che permette in una comunità – classe di suscitare domande legittime, la cui risposta non è scontata e di trasformarla in una comunità di apprendimento. Questo non esclude un sapere del docente relativo al come si studia, come si trovano le informazioni che interessano, come trattarle e con quali domande opportunamente guidate. Ma non esclude neanche un sapere relativo al cosa, cioè alla storiografia sull’argomento scelto, al tipo di fonti da utilizzare ecc. Una cosa mi era e mi è chiara: gli studenti per essere motivati devono avere l’idea di scoprire qualcosa di nuovo, di cui neanche l’insegnante sa niente, devono avere l’idea di compiere un‘esperienza di conoscenza naturale e non artificiale, cioè già costruita e che necessita solo di essere trasmessa. Occorre quindi non separare i problemi dell’insegnamento/apprendimento della storia da quelli relativi alla ricerca didattica e alla ricerca storica disciplinare: non scindere il chi del docente e il chi dello studente dal che cosa e dal come.[ii]
Il chi dello studente
Le notizie biografiche degli studenti le avevo raccolte per conoscere la loro soggettività ma soprattutto per far loro capire come il tempo storico si struttura in modo diverso da quello semplicemente cronologico, e che quindi il tempo ha una durata, dei cicli, si può periodizzare ecc. La storia della loro vita ha fornito loro uno schema semplice di linea del tempo cui possono essere applicate tutte le categorie temporali che lo storico usa nell’analisi di un fenomeno. Ma essa mi ha anche dato segnali acuti di una insofferenza nei confronti del loro presente, di una identità incerta che si organizza e tenta di strutturarsi all’interno dei gruppi di pari. Il rapporto con il mondo esterno è invece di chiusura, di indecifrabilità.[iii]
La lettura degli articoli di Umberto Fiori e Alberto Rollo sulla città di Milano[iv] mi ha fatto capire quanto importante sia riconoscersi nei segni del mondo che abitiamo per acquisire sicurezza individuale, per trovare memoria di sé e delle generazioni che ci hanno preceduto.
La mia stessa esperienza di immigrazione a Milano da un paese della Sicilia, mi ha fatto toccare con mano quanto contino il conoscere e il riconoscere i luoghi che attraversiamo per sentirsi pienamente consapevoli e cittadini degli spazi che altrimenti viviamo in modo estraniato.
Il cosa con chi
Ho individuato il tema attorno al quale far ruotare il programma di storia e letteratura nelle classi di terzo e quarto anno: la città come spazio pubblico, intesa nel senso più antico del termine, come polis, spazio della politica e della cittadinanza, spazio della relazione tra uomini liberi ed eguali. Attraversare il deserto[v] (Arendt) della città per renderla famigliare, vicina, e insieme prenderne le dovute distanze attraverso un processo di allontanamento nel tempo, di proiezione quasi virtuale e tridimensionale supportata da foto d’epoca, edifici e strutture di fabbriche ancora esistenti. Un modo per far rivivere la storia di parole senza senso, per loro, dei manuali di storia, in vita di cose, pietre, case, oggetti ancora esistenti e parlanti purché sottoposti a domande.
Mi è sembrato che restituire allo sguardo degli studenti una città non più muta e senza volto, ridare identità e storia a un quartiere (la zona di Porta Romana) in cui riconoscersi e ritrovarsi, potesse riconciliare gli studenti con se stessi, con le proprie radici e con uno spazio urbano da vivere con maggiore famigliarità e con tutta la dimensione psico-fisica che l’atto dell’esperire comporta. Si trattava innanzi tutto di attivare un’educazione dello sguardo che andasse oltre la facciata delle forme con cui gli edifici si mostrano, di insegnare cioè a interrogare le case, le strade, la forma stessa di una città e di un quartiere e a dialogare con essi, per capirne l’origine, il significato, la funzione e i loro mutamenti nel tempo. Soddisfare insomma quello che per Walter Benjamin è l‘ininterrotto “bisogno dell’uomo di una dimora”. Per questo sono partita dal presente, da come oggi gli studenti percepiscono la città contemporanea, la metropoli milanese dove, secondo Giancarlo Consonni, “la funzione circolare ha sottomesso a sé la funzione abitare “[vi], distruggendo i luoghi e impedendo qualsiasi legame tra spazio e identità individuale e collettiva. “Sempre più affastellato di oggetti, anzi, disarticolato in un insieme di oggetti esso stesso, lo spazio che subiamo è organizzato come quel magazzino in movimento che costituisce il cardine dell’organizzazione fordista”[vii]. Riscoprire la polisemia dei caratteri fisici del passato inscritti nel corpo della città e del nostro quartiere significava riaprire un dialogo tra presente e passato, sfuggire al flusso delle trasformazioni utilitaristiche che azzerano la memoria, ricostituire la memoria dei luoghi e degli eventi che li hanno attraversato, che diventi bussola, “strumento di orientamento nel mutamento (..) e [ricostituire] la stessa fisicità della città come ‘sussidio mnemonico per il passeggiatore solitario’ (W. Benjamin)”[viii].
” Sinceramente io vivo questa città in modo indifferente, perché tutto ciò che accade dentro non mi interessa più di tanto. Infatti, a me basta il mio spazio nel quale sto con i miei amici, dove possiamo trovare tempo per svagarci e divertirci insieme. (…) Il problema è che la città, essendo molto grande e piena di gente, è molto caotica e frenetica.” (Fabio Specchia, III A)
” (…) Così ora mi viene lo stress a stare ancora in giro per Milano, dopo più di sette ore passate a scuola: troppo caotica, troppo inquinamento, troppa fretta nella gente di fare ogni cosa, un enorme desiderio di avere tutto e subito, di seguire necessariamente la moda, di essere sempre in ordine fisicamente.” ( Paola Italia, III A)
” (..) Nelle grandi metropoli una persona vede migliaia di facce ogni giorno senza sapere chi sono, mentre ( in paese) sapendo chi vedi puoi salutare e fermarti a parlare e questo dà un senso di unità maggiore. (…) La tranquillità del paese rende la vita molto calma e piacevole, senza gli stress del traffico, delle code e della frenesia della vita da città.
Il mio stile di vita è cambiato da circa tre anni, perché da quando vengo a Milano per andare a scuola sono diventato più agitato e più frenetico, rendendomi sempre scontroso con la maggior parte delle persone che conosco.” (Andrea Casini, III A )
I testi degli studenti confermano un’immagine della propria città come spazio caotico frenetico, senza senso, in cui si affastellano velocemente, oggetti, persone, automobili; oppure come uno spazio ristretto, il recinto chiuso del gruppo degli amici che può salvare dall’estraneità con cui si vive il mondo esterno, in cui il presente viene assolutizzato in un identico sempre uguale e l’altro da sé, il lontano dal tempo e dallo spazio in cui si vive vengono rifiutati come minacciosi. Questo fenomeno della presentificazione così viene spiegato da Paul Fraisse: “Il restringimento dell’orizzonte temporale al solo presente è il frutto di processi di difesa dell’individuo contro i pericoli che provengono dal passato o dall’avvenire che sembrano minacciare la sua integrità.”[ix]
Reinhart Koselleck, esaminando il manifestarsi dell’idea di progresso nel XVIII secolo, afferma: “Il tempo accelerato, ossia la nostra storia, abbrevia gli spazi dell’esperienza, li priva della loro stabilità, e in tal modo mette continuamente in gioco nuovi elementi ignoti; così, a causa della complessità di questi fattori sconosciuti, persino il presente si sottrae alla nostra esperienza.”[x]
A differenza però dell’uomo del ‘700 che guarda al futuro e “desidera accelerarlo con la propria opera”[xi], recuperando il presente privo di esperienza nella filosofia della storia, il nostro studente ha perso la possibilità di fare esperienza ma anche la fiducia in qualsiasi ideologia progressiva, quindi non ha aspettative rispetto al futuro. L’impossibilità dell’esperienza e la complessità caratterizzano la modernità in cui la velocità e la molteplicità delle trasformazioni lasciano gli uomini ammutoliti, senza le parole per raccontare un’esperienza che quindi non può sedimentarsi, non può diventare Erfahrung, “(…) dati accumulati, spesso inconsapevoli, che confluiscono nella memoria” (Benjamin) e si fondono con quelli della memoria collettiva. La modernità rende indicibile un “vissuto” il cui senso non si coglie né è possibile ritrovare in una comunità frantumata. Resta l’esperienza come Erlebnis, flusso di vissuto mai pienamente interpretabile né possibile oggetto di narrazione, che segna la pluralità e la relatività dell’uomo franto del ‘900[xii].
La classe come comunità di apprendimento può virtualmente rifondare una soggettività collettiva in cui la memoria individuale, di ogni componente, trova ascolto e senso nella memoria collettiva? Può costituirsi come comunità ospitale che, come scrive Consonni per la città, accoglie la molteplicità e la diversità, pur mantenendo ognuno la propria singolarità?
La curiosità di conoscere e la disponibilità a sottrarsi all’indifferenza diffusa sono anche i desideri degli studenti che convivono con l’immagine negativa della città in cui vivono.
“(…) io sono del parere che bisogna avere la mente aperta a nuove esperienze ed evitare di rinchiudersi in un luogo, per alimentare la voglia di conoscere, di scoprire e di osservare anche ciò che di solito si guarda ogni giorno con totale indifferenza”. (Pedra Piccu, IV A)
” Mi ricordo che quando avevo nove anni prendevo un cannocchiale e dalla finestra di casa mia guardavo dentro la Falck, per vedere i rottami delle macchine che venivano buttate da una ruspa dentro un macchinario che le riduceva in pezzettini piccoli di ferro.
Adesso non c’è più niente, c’è il deserto, la gente è più vecchia (.. .) I giovani cercano di trovare lavoro altrove e intanto il degrado di questa città [Sesto S. Giovanni] cresce.
Secondo me, una città per funzionare deve avere il lavoro, solo questo può cambiare il rapporto gente – città, se c’è il lavoro c’è tutto, cioè funziona tutto”. (Marco Pirola, IV A)
Tematizzazione
Il tema della città, trattato durante l’anno sotto angolature diverse e da discipline come storia dell’arte, lingua francese e lingua tedesca, mi sembrava troppo vasto. Avevo bisogno di circoscrivere il campo nello spazio e nel tempo. La zona attorno a corso di Porta Romana, dove è situata la nostra scuola, mi sembrava un ideale oggetto di studio, perché essa fa parte della quotidianità degli studenti, siano essi abitanti della zona, siano abitanti di altre zone o di paesi dell’hinterland, quindi poteva essere lo spazio comune condiviso da tutti e non conosciuto profondamente perché attraversato di fretta, anonimo, senza volto.
L’arco cronologico scelto è stato casuale, legato ai programmi. Nella classe terza ho sviluppato questo tema e ho scelto il Medioevo e il Rinascimento come sfondo temporale (ma di questo lavoro non racconterò nulla in questa sede), nella classe quarta ho individuato l’Ottocento e il Novecento da proseguire in quinta.
Inizialmente il lavoro avrebbe dovuto interessare le classi seconde terze e quarte e avere un carattere interdisciplinare. Era previsto nel progetto originario (promosso da tutto il gruppo di materia di Italiano e Storia) l’intervento con gli studenti di studiosi del territorio di Milano sia dal punto di vista storico e architettonico (il prof. Antonello Negri, docente di Estetica all’Università Statale, che si occupa di archeologia industriale, il prof. Giancarlo Consonni, docente di Architettura al Politecnico di Milano, la prof.ssa Annarita Buttafuoco, docente di Storia del Risorgimento all’Università di Siena, il prof. Gianfranco Petrillo, storico dell’Istituto milanese di Storia dell’Età Contemporanea, della Resistenza e del movimento operaio), sia dal punto di vista letterario. La poetessa Vivian Lamarque avrebbe dovuto fornire un quadro di Milano nella rappresentazione poetica e narrativa. Ovviamente gli incontri sarebbero stati preceduti da un’attività didattica dei docenti sui temi da loro trattati. Poiché i finanziamenti previsti non sono arrivati e la scuola non era disposta a pagare, siamo riusciti a realizzare solo l’incontro con il prof. Consonni, che si è prestato gratuitamente.
A questo punto, fallito il progetto iniziale di lavoro con più classi, io ho proseguito con il mio consiglio di classe, circoscrivendo moltissimo il terreno di intervento e di studio con gli studenti.
Finalità
1.
- Rimotivare gli studenti allo studio della storia, inteso non in modo passivo ma ausiliario ad una ricerca in progress inserita nel curriculum interdisciplinare delle classi quarte.
- Ridare senso al ruolo degli studenti restituendo loro un sapere fondato sull’esperienza del fare e vivere dentro spazi conosciuti anche se in modo non sempre consapevole.
- Valorizzare le identità dei singoli attraverso il confronto con le differenti memorie che essi stessi o altri hanno dei luoghi oggetto di interesse.
- Costruire un’equipe di lavoro e di studio che, pur nelle diversità geografiche e culturali, ritrova somiglianze e affinità in soggetti o situazioni appartenenti ad un passato storico più o meno recente.
Obiettivi
2.
Le abilità che si intendevano mettere in gioco e sviluppare nel progetto iniziale erano le seguenti:
2.1. Tessere un filo conduttore tra presente, passato, presente.
2.2. Orientarsi nello spazio e nel tempo attraverso mappe storiche tematizzate.
2.3. Selezionare e interrogare fonti scritte, orali, monumentali, materiali e iconiche:
documenti scritti, testimonianze, fotografie d’epoca, edifici, oggetti ecc.
2.3. Selezionare informazioni dalle fonti sulla base delle domande poste ad esse
dallo studente.
2.4. Formulare problemi e ipotesi interpretative.
- Individuare e schematizzare modelli di spiegazione dalla storiografia
sull’argomento.
- Confrontare le ipotesi formulate dagli studenti con i modelli di spiegazione
storiografici.
- Riconoscere e trattare le diverse categorie temporali: durata, ciclo, periodo, ecc.
- Individuare nel presente le permanenze e i cambiamenti subiti dal campo di indagine, visibili nello spazio e deducibili dall’analisi delle fonti, espressione di fenomeni storici di lunga durata.
- Ricostruire attraverso le fonti il panorama economico, sociale e culturale dell’area studiata.
- Elaborare per iscritto i risultati della ricerca.
L’inizio
Sono partita dalla necessità di mostrare il tempo storico iscritto su un corpo – materia fatto di carta e di pietra: le mappe storiche della città industriale e l’osservazione degli edifici, reperti di archeologia industriale.[xiii]
Avevamo già studiato la rivoluzione industriale inglese, capito alcuni modelli di spiegazione, letto le diverse interpretazioni che se ne danno, individuato la singolarità del caso inglese rispetto ai casi tedesco, italiano o francese ecc. Per quanto riguarda l’Italia economica dell’Ottocento avevamo passato in rassegna le diverse Italie produttive, analizzato le differenze e così via.
Nel saggio di Antonello Negri I luoghi del lavoro[xiv] ho trovato una sintetica ma precisa ricognizione degli stabilimenti presenti a Milano tra Ottocento e primo Novecento sulla base delle mappe industriali di Milano del 1881 e del 1914, allegate; in quello di Ornella Selvafolta L’abitazione operaia e i servizi[xv] è indicata la mappa dei servizi presenti a Milano tra il 1881 e il 1914. Utili, per iniziare il lavoro, sono state due schede relative al Bottonificio Binda, sito in corso di Porta Romana 122[xvi] e allo stabilimento metalmeccanico Tecnomasio Brown Boveri (TIBB)[xvii] sito in piazzale Lodi 3 dal 1907, nato però in via Pace 10 nel 1864 con la denominazione “Strumenti d’ingegneria e dinamo Tecnomasio Italiano”[xviii].
Diedi ad ogni studente una copia della mappa industriale di Milano del 1881[xix] e quella del 1914[xx]. Non volevo leggere subito il saggio di Negri ma preferivo far individuare agli studenti la tipologia delle fabbriche e le diverse aree di Milano coinvolte.
La prima mappa segnava gli opifici o manifatture presenti in Milano fino al 1881. Delimitammo la zona di Porta Romana, non senza però avere notato la caratteristica comune di questi insediamenti produttivi: si trattava di litografie, tipografie, tintorie, saponifici, opifici tessili, ad eccezione della Tecnomasio italiano. Mancavano ancora le grandi industrie. Questa lacuna agli studenti era visibile scorrendo i nomi nella legenda della mappa. La mappa del 1914 già indicava alcune fabbriche di grosso respiro e lo spostamento dell’asse industriale verso Sesto e Niguarda, la Stazione elettrica di Porta Romana, nonché le nuove stazioni ferroviarie che furono costruite in quegli anni, lungo gli assi urbani della prima industrializzazione milanese fuori dalle mura spagnole, per soddisfare i bisogni commerciali delle nuove fabbriche, come la Stazione merci di Porta Romana; erano segnati anche le nuove stazioni e gli scali progettati al 1914: la Nuova Stazione centrale, la nuova stazione di Porta Vittoria, la nuova stazione di San Cristoforo, il nuovo scalo merci Farini. Lungo l’asse di corso di Porta Romana, ex decumano della città imperiale, cerchiammo gli indirizzi delle fabbriche.
Avevamo ancora in mano dei nomi che, però, potevano animarsi e avere una voce e un volto solo se noi avessimo posto loro delle domande. Quali? Via via i problemi emergevano e ognuno li appuntava sul quaderno di storia. Gli studenti avevano in mente i problemi connessi a all’industrializzazione in Inghilterra: rapporto città campagna, provenienza territoriale degli operai, composizione per sesso ed età degli operai, organizzazione del lavoro di fabbrica, le lotte operaie, rapporto con il mercato e volume degli affari., provenienza del capitale iniziale.
Queste le prime domande. Successivamente diedi loro le due schede sul bottonificio Binda e sulla Tecnomasio Brown Boveri. La prima scheda sembrò loro più interessante. In quarta si stava studiando il ’48 a Milano e questa fabbrica fu costruita nel 1847 dall’ingegner Girolamo Rovaglia. Sembrava più vicina al periodo storico che sul manuale si stava studiando.
Sulla base delle domande posteci prima, chiesi di selezionare le informazioni e di incominciare a redigere una rassegna di fonti e una bibliografia ragionata relativa alle informazioni che noi cercavamo. Già questa scheda sul bottonificio ci forniva informazioni motivate da indicazioni bibliografiche e di fonti che bisognava controllare.
Una pista
Le direzioni che prendemmo furono due: da una parte ricerca in biblioteca dei titoli già segnalati e ricerca per soggetto, dall’altra verifica sul territorio dell’esistenza della struttura della fabbrica “Binda”. Prima ancora di arrivare alle fonti fornii una piccola bibliografia sulla storiografia già esistente. Il volume, curato da F. Della Peruta, Storia illustrata di Milano mi sembrava di facile comprensione e godibilità per le illustrazioni riprodotte. Dall’indice individuammo due saggi interessanti, quello di F. Della Peruta Lavoro e fabbrica dall’Unità alla prima guerra mondiale[xxi] e quello di R. Romano Da Pirelli a Falck[xxii]. Segmentai il primo, distinguendo le due fasi dell’industrializzazione milanese e chiesi agli studenti di selezionare le informazioni contenute sulla base delle domande già prima concordate. Nel saggio c’erano informazioni sulla composizione geografica e sociale della classe operaia milanese, i dati sull’immigrazione, la tipologia delle fabbriche presenti a Milano nelle varie zone, le caratteristiche del decollo e la peculiarità dello sviluppo industriale italiano. Si tratta di un saggio generale ma che poteva dare l’idea di come si muovevano uomini e cose in quegli anni. Chiesi di tabulare le informazioni sulle fabbriche, individuando il numero di addetti per sesso (se era indicato), e la posizione nel territorio; di confrontare questi dati con quelli già conosciuti delle mappe industriali del 1881 e del 1914. Nel saggio di Romano diedi il compito di individuare le caratteristiche del ceto imprenditoriale milanese, tra cui spiccava Ambrogio Binda: l’atteggiamento quindi degli imprenditori nei confronti della classe operaia, da “questurini” come alla Breda e alla Pirelli, al falso paternalismo di Ambrogio Binda che si faceva chiamare “amorosissimo padre” (Romano). Per smontare questa immagine paternalistica di Ambrogio Binda, Romano denuncia le pessime condizioni di lavoro degli operai e ci dà una informazione importante citando, “La Gazzetta ufficiale di Milano” del 1856, già segnalata da Maglioni che però ometteva la presenza femminile nelle fabbriche. Eccola:” Si rimane stupefatti alla vista di quelle femmine, le quali, fra lo stridore delle ruote, obbligate a starsene silenziose e immobili, col volto e colle vesti coperti della polvere d’osso ond’è pregno l’ambiente, hanno sembianza di statue irruginite, il moto regolativo delle loro mani sudicie offrendo il solo indizio di vita e di intelligenza”[xxiii]. Questa immagine ci colpì molto e si voleva andare più a fondo. La domanda successiva fu questa: come reagivano gli operai?
Ci mettemmo al lavoro per recuperare la “Gazzetta ufficiale di Milano” e trovare informazioni sulla classe operaia milanese delle origini. Volker Hunecke, in Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano[xxiv], colloca la nascita delle prime fabbriche milanesi all’interno del dibattito sull’industrialismo in Lombardia prima e dopo l’Unita d’Italia: da una parte la resistenza degli anti industrialisti, che si richiamavano a valori etici ed erano preoccupati della condizione proletaria “disumana” e minacciosa dell’armonia sociale”, dall’altra quella degli industrialisti preoccupati dell’insorgere del problema sociale in una società industrializzata: molto meglio il decentramento nelle campagne e il mantenimento dell’unità famigliare attorno al lavoro a domicilio.[xxv] Di fronte a tante resistenze sembra ancora più eccezionale la nascita di grosse fabbriche come quella di ceramiche Richard o quella di Ambrogio Binda che occupava 600 operai. Se dunque grosse fabbriche con un alto numero di addetti, una efficiente organizzazione del lavoro e investimenti tecnologici già sono testimoniate negli anni ’50 dell’Ottocento (cfr. “Gazzetta Ufficiale di Milano”, “Eco della Borsa”), come mai il decollo industriale in Italia avviene solo negli anni Novanta?
Hunecke sostiene la tesi di Vittorio Ellena, secondo cui “l’inferiorità” economica dell’Italia era da addebitare alla mancanza di capitali, causata non da una loro inesistenza in assoluto ma dalla”mancanza di fiducia nelle imprese industriali”[xxvi].Egli condivide parzailmente la tesi di Gerschenkron[xxvii] che fa risalire il mancato sviluppo italiano all’assenza di banche considerevoli. Secondo Hunecke, i capitali in Lombardia c’erano ed erano rastrellati dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per finanziare l’agricoltura o le attività immobiliari. C’era una grande sfiducia nei confronti dell’imprenditoria industriale ed il proletariato di fabbrica era vissuto come una minaccia sociale. Secondo lo storico Gino Luzzato, si consuma “un ritardo di circa un ventennio nello sviluppo economico della Lombardia tanto promettente prima del 1847”[xxviii]. Negli anni novanta cambiano le banche (banche miste tedesche) e c’è sviluppo industriale, come sostiene Gerschenkron. Ma tutto questo avviene, secondo Hunecke, perché cambia l’iniziativa imprenditoriale e quindi le banche diventano “fattore strategico”(Gerschenkron). Il modello italiano di sviluppo, prima del decollo, si fonda, invece, su un piccolo capitale iniziale, un’offerta illimitata di forza lavoro, bassi salari, tecnologia arretrata e decentramento industriale.
I primi pionieri dell’industria milanese acquisiscono capitali tra amici e soci fondando delle società per accomandita come Richard nel 1842 o come Binda per la costruzione della cartiera nel 1855.[xxix]
Ma dove prese i capitali Ambrogio Binda quando fondò la su prima fabbrica di bottoni nel 1847?
Un’opera di Achille Caprari[xxx] pubblicata per la prima volta nel 1874, rende omaggio alla vita di Ambrogio Binda ricostruita dall’infanzia sino alla sua morte. Si tratta di un libro per “l’istruzione primaria” il cui scopo è “fornire un mezzo, onde l’esercizio della lettura nelle prime scuole giovi principalmente all’educazione dell’animo, coll’instillarvi il desiderio delle virtù, che nella povertà e nelle disavventure sorreggono l’uomo a vincere la fortuna”[xxxi]. Infatti “Le rappresentazioni momentanee e successive d’aspetti diversi non impressionano così al vivo gli animi come il ritratto di un tipo solo, ammirato in ciascuno de’ suoi particolari”. La vita di Binda è proposta come esemplare per le giovani generazioni, rappresenta il modello del self-made man, l’uomo fattosi da sé, secondo lo stile e il modello proposti da Samuel Smiles, la cui opera Self-Help, viene tradotta e stampata in Italia nel 1865 [xxxii].
Ho diviso i capitoli del libro di Caprari sulla base delle seguenti domande: come Binda accumula i capitali necessari per la costruzione della fabbrica in corso di Porta Romana; a quale mercato si rivolge; quali tecnologie usa; qual è il volume degli affari.
Il capitale iniziale è frutto di risparmi accumulati dall’età di nove anni, siamo nel 1818, quando orfano e scappato da Gallarate, dove era vissuto, si impiega presso “il Vigoni, rinomato artefice di passamani”[xxxiii]. Dopo nove anni di lavoro, nel 1829, ha risparmiato venti lire. Si licenzia da Vigoni e compra due telai e alcuni pettini, quindi si mette a lavorare in proprio e a vendere la sua merce, trova poi “il modo di ottenere un tessuto a quadretti, come si richiede per guarnire l’anima di legno de’ bottoni, […] e n’ebbe straordinario profitto”[xxxiv]. Nel 1835 arrivano in Italia dall’Inghilterra i bottoni fabbricati a macchina e Binda “si propose di fabbricarne anch’esso di simili”[xxxv] Costruisce una “trancia adatta all’uopo” e inizia la sua fortuna data dal prezzo basso e dal prodotto eccellente . Compera nel 1842 una casa al Ponte di San Celso e la trasforma in opificio, sicché “dal 1842 al 1847, la novità e il pregio delle merci, la insolita dovizia dei lucri, la estensione e importanza dei traffici levarono alto nella classe de’ principali mercatanti europei, il nome oscuro di [..] Ambrogio Binda”.[xxxvi] ” Con la prosperità delle imprese con la accumulata copia de’ mezzi, cresciutogli l’animo, cominciava il Binda nel 1847 la costruzione di un grandiosissimo opificio e insieme di un sontuoso palazzo sul corso di Porta Romana”[xxxvii]. Nel 1855, nonostante le perdite subite nel ’48 da cui esce producendo bottoni di metallo di cui c’era una grande richiesta, con alcuni amici forma una società e compera una fabbrica di pettini e nel 1855 la cartiera a Conca Fallata e nel 1867 la cartiera della Ditta Maglia a Vaprio d’Adda.
Il Caprari, al di là del contesto ideologico in cui le colloca, ci ha fornito informazioni che ci hanno spinto a cercare fonti più dirette sull’attività della fabbrica, per capire come essa abbia potuto reggere il mercato internazionale, al punto da fargli affermare che “la Casa Binda pose ragioni di traffico, senza competenti rivali, in tutti i paesi d’Europa e fuori.” [xxxviii].
L’articolo di D. L. Magrini pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Milano del 7 novembre 1856, ci ha fornito informazioni di prima mano. Secondo il giornalista, che ha visitato la fabbrica, questa occupa 800 operai d’ambo i sessi “per la maggior parte dell’anno”. ” Vi si scorgono vaste officine per la preparazione delle materie prime; e una allestita allo scopo di riparare, e costruire eziandio, pezzi di macchina e macchine intere per gli usi dello stabilimento: Meritano speciale menzione quattro saloni ove per frequenti e ampie finestre si gode il benefizio di viva luce, ove l’occhio si perde tra lunghe fila di tornj e strettoj nel più bell’ordine collocati”. Magrini ammirava “la nettezza e pulizia, l’accurata sorveglianza e un controllo puntualissimo delle singole operazioni”. Quindi descrive le varie fasi della costruzione dei bottoni in osso: dalla messa a bagno delle unghie di “quasi tutti gli animali” dentro grandi tinozze per 9 o 10 giorni nel cortile della casa poi alla bollitura in una caldaia, quindi vengono depurati delle parti inutili per la lavorazione e fatte essiccare sopra una graticola di carboni ardenti, poi sottoposte alla pressione del torchio e ridotte in lamine sottoi piastre di ferro riscaldate. Queste a 16 o 20 per volta “si dispongono verticalmente tra il fondo e lo stantuffo alzato d’ogni strettojo, interponendovi le unghie, preparate nel modo su descritto”. ” La forza muscolare di due uomini viene applicata ad “una leva a cricco di Garoussé“, per far azionare gli strettoj. Dopo l’essicatura delle lamine 22 macchine le tagliano e le forano, altre le raschiano, dei nuovi coloranti chimici colorano le animelle dei bottoni, vengono quindi apposti i gambi o i picciuoli dalle lavoratrici “con un meccanismo per cui si possono attualmente preparare centinaia di gambi nel tempo che per lo passato bastava appena a formarne un solo”. Questo meccanismo si chiama trafila. Vi sono inoltre 230 macchine per coniare i disegni che imitano i bottoni di seta ma hanno più durata. Quindi passano alla mola fatta roteare dalla forza di un cavallo.
Le unghie provengono metà dalla Lombardia e l’altra metà dall’America specie meridionale. “Alla produzione dei bottoni di madreperla si destinano quattro mole, trenta torni e due macchine per disegni. Per i bottoni di stoffa o di seta Binda usa macchine inventate da un “rinomato manifattore di Parigi, Samuele Dalton” e perfezionate e semplificate dagli inglesi. Binda usa 150 di queste macchine, dette macchine d’aggroppare.
Si trattava, quindi, di una fabbrica di tipo nuovo in quegli anni, lodata da Magrini per gli “eccellenti arnesi” adoperati, per la “buona divisione del lavoro”, per l’ordine e la pulizia degli stanzoni, infine per la disciplina degli operai. Le maestranze di questa fabbrica provenivano dalla campagna ed erano composte per due terzi da donne, fanciulle e fanciulli, facilmente disciplinabili: nel 1862 su 330 operai 180 erano donne, nel 1881 aumenta il numero degli addetti e delle donne impiegate (500 donne e 200 uomini) [xxxix].
Il passato nel presente
Il passo successivo fu il sopralluogo esterno svolto da tutta la classe al pomeriggio con la mappa del 1881 sotto gli occhi e una macchina fotografica tra le mani. La domanda che ci eravamo posta era: che cosa era cambiato dal 1881? Avremmo trovato ancora le fabbriche dell’epoca? Sia io che gli studenti partivamo da un’ignoranza comune su quello che avremmo trovato. Io certamente avevo già visto per conto mio che cosa era rimasto, ma non mi sembrava onesto farlo sapere subito agli studenti. Di una storia è meglio non sapere subito la fine, per gustarla meglio.
Subito svoltando a destra della nostra scuola, tra via dei Pellegrini e via Madre Cabrini, ci imbattemmo nel numero civico 122 di corso di Porta Romana, segnato nella mappa come fabbrica di bottoni Ambrogio Binda. Il palazzo si presentava in buone condizioni e confermava la descrizione di Maria Teresa Maglioni, compilatrice della scheda sulla fabbrica Binda in “Quaderni di documentazione regionale”: impianto dell’edificio ad “U”, costruito a bugnato su tre piani per la famiglia e gli eredi (cfr. Ambrogio Binda), il piano terra destinato ai magazzini e agli uffici di vendita e sulla destra in fondo al cortile i capannoni per le attività produttive, distrutti dalle bombe del II dopoguerra, come ci disse poi la portinaia dello stabile. La facciata esterna di gusto neoclassico, curata nei particolari, presenta le finestre, con architravi e timpani, decorate da protomi leonine. Non mancano il fregio e il triglifo nella parte finale prima delle grondaie del tetto. Al centro e in alto sopra il portone ad arco la protome di Mercurio, dio protettore dei commerci, lasciava intuire che quella casa una volta non era servita solo ad abitazione. L’eleganza e l’armonia delle forme architettoniche evoca l’osservazione estetica di Negri: “In primo luogo le facciate dei capannoni, o i loro fronti lungo le vie cittadine, si caratterizzano sempre per la ricerca di una minima gradevolezza formale, di un tocco di ‘stile’, di piccole aggiunte decorative che sembravano poter elevare in qualche misura il tono più che dimesso di un’edilizia puramente funzionale.”[xl]
Dall’altro lato della strada al 113 avrebbe dovuto esserci la fonderia di caratteri G. Commoretti e Figlio, ma l’edificio che avevamo di fronte era stato costruito negli anni ’60 quindi della vecchia struttura non restava nulla.
Entrando nel palazzo Binda si accede in un doppio androne arredato con mobili d’epoca e dominato dalla presenza di due statue leonine, già richiamate nelle protomi alle finestre e simbolo della casa, a sinistra della bussola, sulla parete, fa spicco una bella stampa della fabbrica con le ciminiere ancora fumanti. Si tratta di una litografia di Giuseppe Readelli, più volte pubblicata intorno agli anni ’50, quando la fabbrica era considerata una meraviglia per l’efficiente organizzazione del lavoro[xli] (Eco della Borsa, Gazzetta di Milano). La portiera ci guidò nel III androne che conduce alle scale per i piani superiori. Di fronte a noi la statua a mezzo busto di Ambrogio Binda salutava i visitatori, sulla parete a sinistra era appesa la pergamena con medaglia d’argento per il premio assegnato al bottonificio nell’Esposizione Industriale del 1881 e in basso poggiato su un mobile un antico torchio per bottoni (l’unico rimasto, ricorda la portiera), sulla parete destra un quadro raffigura Ambrogio Binda. Sulla parete sinistra una porta chiusa e senza insegna conduceva al laboratorio-ufficio di bottoni, operante fino a qualche anno fa (portiera vox). Passammo nel giardino all’italiana ben tenuto e oggi ricco di alberi robusti, ancora piccoli e sparuti nella litografia di Readelli. La portiera ci fece vedere le costruzioni nuove che hanno sostituito i capannoni produttivi, il sentiero che attraversava il giardino percorso dai carri carichi di merce in uscita nel II ingresso che si affaccia in via dei Pellegrini, infine ci informò dell’esistenza di un canale che passava vicino ai capannoni e che forniva energia idrica. Ci raccontava di Ambrogio Binda come se l’avesse conosciuto, in realtà faceva riferimento, scoprimmo, ad un’altra fonte più diretta, e cioè l’erede dei Binda, la signora Carla Binda Albertoni.
La portinaia come fonte orale non era molto attendibile, perché le sue informazioni erano di seconda o terza mano. Ci raccontò, per esempio, che Ambrogio Binda s’era arricchito vendendo i bottoni con il carrettino in piazza del Duomo, informazione che ci fu poi ripetuta dalla signora Binda ma che non abbiamo trovato in nessuna fonte scritta. Tuttavia avevamo scoperto che c’era un’altra fonte orale più diretta, l’erede di Ambrogio Binda, che forse ci avrebbe fornito documenti più sostanziosi. Mi feci dare il recapito telefonico. La signora Binda abitava lì nel palazzo, come del resto tutti i parenti più o meno diretti di Ambrogio Binda e in questo le intenzioni del nostro, all’atto della fondazione del palazzo, non sono state disattese.
Carla Binda Albertoni ci ricevette quattro volte nella sua casa, anche se si trovava in condizioni di salute non ottimali. Oltre alla macchina fotografica ci portammo due registratori.
Scoprimmo così che lei aveva gli archivi della fabbrica che aveva chiuso i battenti solo negli anni ’70, anche se dalla fine degli anni ’50 non produceva più ma era solo una società commerciale diretta da lei con alle dipendenze una sola impiegata Isolina, in fabbrica dalla fine dell”800, quando aveva solo 15 anni. Un’altra fabbrica, il cui proprietario era un ex operaio della Binda, li produceva con il marchio Binda e la signora Carla si occupava del mercato. Un mercato vastissimo che comprendeva l’lndia, l’Africa ecc. Ci fece vedere quello che conservava a casa: un archivio fotografico della famiglia Binda, un archivio campionario dei bottoni dall’Ottocento ad anni più recenti, un archivio cartaceo che si trovava in cantina, e un altro archivio non ancora consultato, relativo agli ultimi 20 anni in cui la signora Binda gestiva la società commerciale. In quello stesso pomeriggio ci fece vedere il campionario dei bottoni. In uno stanzino dell’ingresso stavano quattro valigie. Le aprimmo e trovammo tante carte di bottoni dalle fogge più disparate. In due stavano quelli più recenti, in osso e madreperla con i due buchini, per intenderci. Nelle altre due, le più vecchie, trovammo quelli in oro e argento. Ogni foglio aveva il suo numero di inventario, a partire dal n.1, e sotto ogni bottone dei numeri con delle sigle. Io ne sapevo quanto i miei studenti, decidemmo così di richiudere le valigie con la promessa di ritornare ad esaminare il loro contenuto la settimana successiva.
Non avevo molta esperienza di archivi, a parte il lavoro con la tesi e un’esperienza con gli archivisti dell’ISMEC (già ISRMO), Giuseppe Vignati e Grazia Marcialis[xlii]. Chiesi delucidazioni a Grazia Marcialis su come trattare queste fonti. Scrivere tutto, mi disse. Segnare tutto, perché anche se non si fosse conosciuto il senso di una sigla o di un numero, incrociando questi dati con altre fonti, le informazioni sarebbero risultate più chiare. La lettera “f” seguita dai numeri avrebbe potuto fornirci notizie utili sul numero di fogli di carte di bottoni prodotti e venduti.
Rispetto al materiale trovato, decisi di circoscrivere l’arco cronologico e di esaminare la produzione di bottoni fino al primo Novecento, escludendo quelli più recenti del II dopoguerra.
Così la volta successiva un gruppo di studenti si mise a fotografare i bottoni e gli oggetti. Un altro munito di carta e penna appuntava nell’ordine il numero di inventario, il numero di “f” e la probabile committenza che era segnata sotto ogni numero. Era un lavoro meccanico e noioso, ma gli studenti per altri due incontri, volentieri segnavano e scrivevano, perché pensavano di scoprire qualcosa di nuovo. Per la schedatura delle carte diedi loro alcune indicazioni relative alla descrizione del singolo bottone: materiale di composizione, forma e grandezza, immagine rappresentata. I fogli indicavano la committenza, la quantità della merce venduta, in alcuni il prezzo di vendita e l’anno di produzione. I bottoni rappresentano stemmi nobiliari, simboli delle società di mutuo soccorso, bottoni per le divise dell’esercito italiano e delle colonie italiane. Abbiamo ipotizzato che, fino almeno alla II guerra mondiale, buona parte della committenza della Binda provenisse dallo Stato o da enti pubblici. Ciò consentirebbe di spiegare la tenuta e il successo di questa impresa nel corso del tempo.
Finalmente la signora Binda Albertoni ci concesse il permesso di entrare nella cantina dove giacevano le casse piene. Si dichiarò inoltre disponibile a far conservare queste carte presso un Archivio qualificato. Mi misi in contatto con Grazia Marcialis e la presentai alla signora Binda, la quale volentieri affidò in deposito tutto il fondo cartaceo della fabbrica all’Archivio dell’ISMEC.
La cantina dove trovammo le sei casse dell’archivio era umida e molte carte erano già deteriorate, impregnate di muffa. Gli studenti erano eccitatissimi e volevano leggere subito il materiale. Tra le carte, ancora da catalogare e da esaminare, abbiamo trovato il Progetto di massima di nuovo Stabilimento della Ditta Ambrogio Binda per la fabbricazione dei bottoni redatto dall’ingegner Luigi Rossi nel 1902. Esso consta di una relazione, di due tavole di disegno, e di due preventivi di spesa relativi alla costruzione dei fabbricati e alla fornitura dei motori a gas e gasogeno. Questa fonte non indica il luogo in cui è stata costruita la nuova fabbrica ma Carla Binda Albertoni ci aveva già parlato di questa nuova fabbrica situata in Viale Campania, semidanneggiata durante la II guerra mondiale e mai risarcita dallo Stato.
Nella relazione, Rossi spiega l’esigenza da parte della ditta Ambrogio Binda di ingrandire la fabbrica, “desiderando procedere alla costruzione di nuovo stabilimento più rispondente ai progressi della propria industria […]”. Qui l’ipotesi, da verificare attraverso lo studio delle fonti, è se il decollo dell’industria italiana ha interessato anche il Bottonificio Binda che, quindi, è stato avvantaggiato dal protezionismo statale di fine ‘800-inizi del ‘900.
Altri problemi sono emersi nel corso delle discussioni suscitate tra gli studenti dalla lettura di queste ed altre carte. Tra essi si può citare, ad esempio, la questione dell’entità del volume degli affari della Binda tra Ottocento e Novecento. Un’altra questione riguarda l’atteggiamento e i comportamenti scarsamente conflittuali degli operai e delle operaie della Binda: era proprio vero ? e, se sì, quale poteva esserne la ragione? Una foto, fornitaci da Carla Binda, riprende le maestranze della fabbrica di Viale Campania nel 1917 con lo stendardo della Società di Mutuo soccorso, voluta dallo stesso Ambrogio Binda per “proteggere” gli operai e forse anche se stesso da eventuali loro turbolenze. Il Libro dei Verbali dei Dopolavoristi, trovato nell’archivio Binda e datato 1929-1948, testimonia dell’ininterrotta fiducia e benevolenza che gli operai nutrivano nei confronti dei loro padroni, quasi a documentare una linea di continuità, passata attraverso il fascismo, tra gli eredi e il “padre amorevolissimo”, come Ambrogio Binda si faceva chiamare.
Un bilancio parziale
A questo punto, sulla base dei testi storiografici consultati e delle fonti a disposizione, abbiamo provato a fare una prima tematizzazione. Ogni gruppo di studenti ha scelto un tema e ha acquisito la bibliografia e le fonti utili per il suo sviluppo. All’interno di ogni tema si sono aperte tutte le questioni interpretative e le soluzioni possibili ai problemi posti e che gli studenti sono stati invitati a risolvere, fornendo delle ipotesi plausibili. Ad ogni tema prescelto corrisponde un capitolo di un eventuale fascicolo finale. I temi individuati sono stati i seguenti:
- La prima industrializzazione a Milano
- Lavoro e fabbrica in corso di Porta Romana (1847- 1914)
- Il Bottonificio Binda: storia della fabbrica e del suo fondatore dal 1846 al 1974.
- Organizzazione del lavoro nello stabilimento Binda: fasi del lavoro, numero e composizione degli addetti per sesso ed età, condizioni di lavoro.
- La produzione dei bottoni Binda: tipologia, committenza e mercato, entità e volume degli affari.
A scuola numerosi sono stati e restano i problemi da affrontare con gli studenti: da quello dell’organizzazione dei tempi da dedicare alla lettura delle fonti a quello della scrittura personale o di un gruppo sulla storia di questa fabbrica. L’intreccio con la storia generale è possibile ma riesce più agevole agli studenti se dilatato nell’arco dei due anni, visto che si affrontano due secoli che pongono problemi diversi. La scrittura storiografica da parte degli studenti è utile perché impone loro il rispetto di un rigore scientifico, ma anche l’attitudine ad usare un procedimento di tipo argomentativo, ad esercitare pensiero critico e mai compiacente nei confronti di una tesi già confezionata. Però questo tipo di scrittura per loro è difficile e richiede la guida dell’insegnante nonché l’apertura di uno specifico spazio-tempo dedicato ad attività di laboratorio[xliii].
Sicuramente tutto il lavoro sulla ricerca, la selezione e la classificazione delle fonti è entusiasmante per gli studenti. soprattutto se applicato alla microstoria. Trasforma questi studenti in piccoli detective alla ricerca di una soluzione. La fase di elaborazione dei dati è, invece, più dura e quindi richiede un’attenzione particolare del docente nel seguire le varie fasi della stesura dei testi.
E’ importante, secondo me, che il lavoro didattico si concluda con un elaborato scritto dagli studenti. Non conta tanto la scientificità e l’originalità del prodotto finale, quanto il prodotto finito in sé che dà l’idea allo studente di un lavoro che ha avuto un senso e una sua visibilità e che gli restituisce la storia della sua esperienza, la misura delle sue competenze messe in gioco e acquisite.
Ovviamente dal punto di vista della ricerca storica, in senso stretto, il campo di indagine è ancora tutto aperto e richiederebbe una progettazione più avanzata e una collaborazione più attenta tra ricerca storica e ricerca didattica. La realizzazione di una mostra dell’archivio Binda, promossa dall’Istituto Professionale “L. V. Bertarelli” e da enti di ricerca storica o da enti pubblici e privati, potrebbe essere un’occasione per il rilancio del dibattito sull’industrializzazione a Milano tra storici, studenti e insegnanti, ma anche per la restituzione alla città di un pezzo della sua storia.
Crediti
C. Brigadeci, Il bottonificio Binda a Milano (1847-1950): un’esperienza di ricerca didattica e laboratorio con le fonti nella scuola secondaria superiore, è stato pubblicato in Il laboratorio di storia. La ricerca storica, a cura di G. Deiana (Polaris,1999).
L’archivio Binda è conservato e consultabile presso ISEC Milano (Fondazione Istituto per la storia dell’età contemporanea – ISEC onlus)
Immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Litografia_Bottonificio_Binda.jpg
Ringraziamenti
Ringrazio Carla Binda Albertoni e il marito per la generosità e la cortesia con cui ci hanno donato il loro tempo e parte della loro storia familiare, nonché per la rara ospitalità che io e gli studenti abbiamo trovato nella loro casa. Questo scritto vuole anche essere un saluto e un ricordo dedicati alla loro memoria, poiché alla fine del 1997 sono venuti a mancare in modo improvviso.
Note
[i] AA. VV. , Generazioni, a cura della Società Italiana delle Storiche, Rosenberg&Sellier, 1993; I. Mattozzi, La storia insegnata, Milano, Ed. B. Mondadori, 1986.;I. Mattozzi, La cultura storica: un modello di costruzione, Faenza, Faenza ed., 1990; I. Mattozzi, La formazione del prof. , in “I Viaggi di Erodoto”, sett. 1994, pp. 86 – 95.
[ii] Cfr.S. Papert, Mindstorms, Milano, Emme Edizioni, 1982; J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Torino, Einaudi, 1968; P. Perticari, Attesi Imprevisti, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.
[iii] Sulla percezione del tempo e l’immagine della storia nei giovani cfr. A. Cavalli ( a cura di ), Il tempo dei giovani, Bologna, Il Mulino, 1985; AA. VV. , Tempo, memoria identità, Firenze, La Nuova Italia, 1986; AA. VV. , Tempo e spazio: dimensioni del sapere, Milano, Bruno Mondadori, 1988; AA. VV. , Immagini della storia: una proposta di lavoro, in ” Cooperazione educativa”, 1989, pp. 22-32; AA. VV. , Come vedi la storia?, in “I viaggi di Erodoto”, n. 19, 1993, pp. 66-77; Nove domande per la storia, ibidem, pp.146-157; C. Leccardi – M. Rampazi, Progetto e memoria, in “Memoria”, n. 22, 1988; C. Leccardi, Alla ricerca del tempo perduto, in “I Viaggi di Erodoto”, n. 10, 1990, pp. 40-61;C. Leccardi, Futuro breve, Torino, Rosenberg&Sellier, 1996; M. Rampazi, Le radici del presente: storia e memoria nel tempo delle giovani donne, Milano, Franco Angeli, 1991.
[iv] Cfr. U. Fiori, Meloni, Verze e misteri buffi, “l’Unità”, 5 agosto 1996, p. 11; A. Rollo, Un’educazione milanese, “Linea d’ombra”, A. XIV, 17, 1996, pp. 65-73.
[v] Cfr. H. Arendt, Del deserto e delle oasi. Frammento 4, in id., Che cos’è la politica?, Milano, Edizioni di Comunità, 1997, pp., 143-146.
[vi] G. Consonni, Internità dell’esterno. Scritti sull’abitare e il costruire, Milano, Clup, 1989, p. 91; cfr. idem, Addomesticare la città, Milano, Tranchida, 1995.
[vii] Id., Internità dell’esterno., cit., ivi.
[viii] Ibidem, p. 177.
[ix] P. Fraisse, Psycologie du temps, Paris, PUF, 1957, p. 183, cit. in C. Leccardi, Il tempo della quotidianità, in A. Cavalli (a cura di ) Il tempo dei giovani, cit., p. .312.
[x] R. Koselleck, Futuro Passato, Genova, Marietti, 1986, p.25-26.
[xi] Ibidem.
[xii] Cfr. P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Milano, Il Saggiatore, 1994.
[xiii] Interventi didattici di questo tipo sono descritti in: M. Negri, La ricerca di archeologia industriale e l’insegnamento della storia, in AA.VV., Ricerca e didattica. Uso delle fonti e insegnamento della storia, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1985, pp. 187-194; A. Bassi, G. Petrillo, G. Vignati, La fabbrica lascia un segno. Ricerca di archeologia industriale e insegnamento della storia: Guida al patrimonio architettonico di Sesto S.Giovanni, “Viaggi di Erodoto”, A. 3, 8, agosto 1989, pp. 90- 114; M. G. Lazzarin, Ripensare la ricerca di storia locale a scuola, in “Protagonisti”, A. XVI, 60, 1995; G. Deiana (a cura di), Alla ricerca della cascina perduta. La città nello spazio e nel tempo: frammenti di storia metropolitana milanese, Liceo scientifico “S. Allende”-Consiglio di Circoscrizione 15- Comune di Milano, Milano, 1992; Id., Quando la fabbrica fa la storia. La città nello spazio e nel tempo/2. Gli studenti alla scoperta del territorio milanese, Liceo Scientifico “S. Allende”, Distretto scolastico 88, Milano 1996; G. Deiana, Io penso che la storia ti piace. Proposte per la didattica della storia nella scuola che si rinnova, Milano, Unicopli, 1997.
[xiv] A. Negri, I luoghi del lavoro, in “archeologia industriale”, 1, 1983, pp. 8-15
[xv] O. Selvafolta, L’abitazione operaia e i servizi, in “archeologia industriale”, cit., pp.16-33
[xvi] M. Teresa Maglioni (a cura di), Fabbrica di bottoni Ambrogio Binda, in A. Garlandini, M. Negri (a cura di) I monumenti storico-industriali della Lombardia, in “quaderni di documentazione regionale”, nuova serie, 17, pp. 304-305.
[xvii] Marica Magni (a cura di), Tecnomasio Italiano Brown Boveri, in A. Garlandini, M. Negri (a cura di), op. cit, pp. 322-323.
[xviii] Istituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio, “Annali /1. Studi e strumenti di storia metropolitana milanese”, Milano, Franco Angeli, 1992, p. 315.
[xix] Mappa Industrie 1881, Localizzazione delle maggiori industrie milanesi al 1881 con l’indicazione della rete ferroviaria e tranviaria extraurbana. Supporto cartografico. Pianta della città di Milano pubblicata per deliberazione della giunta municipale, 9 giugno 1876, Milano, Premiato stabilimento dell’editore Vallardi, IV edizione,1884, Civica raccolta di stampe Bertarelli; cfr. anche “archeologia industriale”, cit., pp. 34-35.
[xx]Mappa industrie 1914. Localizzazione delle maggiori industrie milanesi al 1914 con l’indicazione della rete ferroviaria esistente e in progetto. Supporto cartografico. Pianta di Milano coll’indicazione del Piano Generale Regolatore Edilizio e di Ampliamento – 1910, Milano, Edizione dello Stabilimento d’arti grafiche A. Bertarelli e C., 1910. Civica raccolta di stampe Bertarelli, Milano; cfr. anche “archeologia industriale”, cit., pp.36-38.
[xxi] F. Della Peruta, Lavoro e fabbrica dall’Unità alla prima guerra mondiale, in F. Della Peruta (a cura di), Storia illustrata di Milano. Milano nello Stato Unitario, Milano, Elio Sellino Editore, 1995, pp. 281-300.
[xxii] R. Romano, Da Pirelli a Falck, in F. Della Peruta (a cura di), Storia illustrata di Milano, cit. , pp. 301-320
[xxiii] D. L. Magrini, I. R. fabbrica nazionale privilegiata di bottoni, oggetti di passamaneria, ecc. di Ambrogio Binda, in “Gazzetta Ufficiale di Milano”, venerdì 7 novembre 1856; cit anche in R. Romano, op. cit., p. 319-320.
[xxiv] V. Hunecke, Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano, 1859-1892, Bologna, Il Mulino, 1982.
[xxv] Notizie su questo dibattito in ibidem, pp. 37-52. La posizione culturale e ideologica di Giuseppe Colombo, industrialista “tiepido” sull’industrializzazione a Milano è chiara in G. Colombo, Milano industriale, in Mediolanum, vol. IV, parte I, Milano 1881, pp. 37-64. Notizie sulla sua attività in C. Lacaita, Giuseppe Colombo, il Politecnico e la Edison in F. della Peruta (a cura di), Storia illustrata di Milano. Milano nello Stato Unitario, cit., pp. 321-340.
[xxvi] V. Ellena, La statistica di alcune industrie italiane, in “Annali di statistica”, serie II, vol. XIII (1880), p. 5-16; cfr. V. Hunecke, cit. p. 79 e seguenti.
[xxvii] A. Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino, Einaudi, 1965.
[xxviii] G. Luzzato, La Lombardia e Milano nel 1859, “Mondo Economico”, 13 giugno1959, p. 14, citato in V. Hunecke, op. cit., p. 88.
[xxix] Un’esperienza di ricerca didattica e ricerca storica sulla cartiera Binda in G. Deiana, Quando la fabbrica fa la storia., op. cit.
[xxx] A. Caprari, Ambrogio Binda. Racconto di A. C. ad uso di lettura nelle Scuole primarie specie nelle serali per artigiani, Parma, Luigi Battei Editore, 1881.
[xxxi] Ibidem, p. 9
[xxxii] Su Binda una descrizione di questo genere si trova anche in M. Lessona Volere è potere, Firenze, 1869, pp. 339 e ss… ; G. B. Cipani, Il futuro operaio. Piccola enciclopedia scolastica pei giovanetti che frequentano le classi superiori delle scuole primarie popolari, 2 voll., Milano, 1884F. Ravizza, Ambrogio Binda nei suoi tempi e oggidì, in Biblioteca “Ambrogio Binda” della famiglia Meneghina. Catalogo compilato dal dott. L. Diotallevi, Milano, 1955. Sulla letteratura del self-help negli anni della prima industrializzazione, si veda G. Baglioni, L’ideologia della borghesia industriale nell’Italia liberale, Torino, Einaudi, 1974, pp.309-365. Sulla funzione di questi libri nella scuola elementare a scopo morale e per il disciplinamento della classe operaia nascente, cfr. D. S. Landes, Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1978. Su Ambrogio Binda e i primi imprenditori milanesi, tra gli altri, si veda G. Fiocca (a cura di), Borghesi e imprenditori a Milano dall’Unità alla I guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 1984.
[xxxiii] A. Caprari, cit., p. 32
[xxxiv] Ibidem, p. 36
[xxxv] Ibidem, p. 37
[xxxvi] Ibidem, p. 37
[xxxvii] ibidem, p. 38
[xxxviii] Ibidem, p. 111
[xxxix] Cfr. De Maddalena, L’industria milanese dalla restaurazione austriaca alla vigilia dell’unificazione nelle rivelazioni della Camera di Commercio di Milano, Milano, 1957, p. 27. De Maddalena fornisce informazioni anche sui salari e il volume degli affari. Sull’attività di Binda , cfr. Atti del Comitato della Inchiesta industriale, vol. V, “Mercerie, bottoni”, 1873-74; F. Borghi, L’industria, in Milano tecnica dal 1859 al 1884. Pubblicazione fatta a cura del Collegio degli ingegneri ed architetti, Milano, 1885, pp. 423-444; G. Benvenisti, L.F. Bolaffio e A. Gramola, Annuario dell’industria e degl’industriali di Milano…, Anno primo, 1890-91, Milano, 1890, pp. 152 e seguenti. Cfr. anche V. Hunecke, cit., p. 176-179.
[xl] A. Negri, I luoghi del lavoro, cit, p. 10
[xli]La fabbrica di bottoni Binda è stata più volte elogiata e descritta da cronisti milanesi negli anni ’50 dell’Ottocento; oltre alla cronaca di Magrini, pubblicata sulla già citata “Gazzetta ufficiale di Milano” del 7 novembre 1856, si veda anche “Eco della Borsa”, 15 maggio 1850.
[xlii]Cfr. C. Brigadeci, A. Criscione, M. Dal Punta, Dalle fonti d’archivio a una mostra didattica, in “Annali/1″cit., pp.559-571.
[xliii] Il dibattito e il confronto di esperienze sul tema del “Laboratorio di Storia” come proposta operativa di innovazione nella didattica della storia sono ampiamente cresciuti nel corso degli ultimi venti anni. Si fa riferimento qui, per un inquadramento teorico del problema e le utili indicazioni fornite, a: I. Mattozzi, Che il piccolo storico sia!, in “I Viaggi di Erodoto”, 1992, n. 16, pp.170-177.