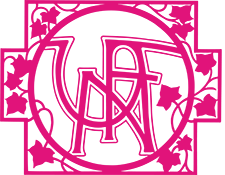L’androgino è tra noi ma è anche dentro di noi, abita il nostro immaginario.
Avrei voluto iniziare questo commento sul libro curato da Barbara Mapelli, L’androgino tra noi (Ediesse, 2016), aggiungendo la locuzione “sempre” al verbo abitare, poi la parola “sempre” mi è sembrata assolutizzante, categorica. Perché per me, in effetti, quel “sempre” è situato temporalmente in una memoria visiva che ha a che fare con il cinema e soprattutto con la televisione della fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, quella dei ragazzi e quella della prima serata.
Certo mi identificavo in Pippicalzelunghe, nelle ragazzine che sapevano fare cose da maschio, nelle eroine in Jeans e pistola dei film western che se la cavavano da sole, o in attrici come Katerine Hepburn che avevano caratteristiche considerate virili e ciononostante erano amate da uomini. Il mio modello di riferimento, quindi, ha un inizio con la nascita della Tv e con la possibilità di accesso ad essa da parte della mia famiglia e sembrerebbe strettamente legata ai consumi degli anni del boom economico.
Prima ancora di avere accesso alla Tv, tuttavia, la mia arena era la strada, i giochi di strada, a nascondino, ai saltelli, o a pulire mandorle fatte asciugare nella strada, o a comprare per mia madre oggetti più o meno pericolosi, dal cibo all’acido muriatico ecc. Si facevano cose da grandi. Non giocavo con le bambole perché non me le compravano e invidiavo le bambine che le possedevano.
Con la presenza della TV, sì, iniziavo ad arrampicarmi sul tetto del terrazzo, a giocare con la pistola che mi aveva regalato il fidanzato di mia sorella, a indossare i jeans, ma solo a casa perché mi erano vietati in pubblico. Mi piacevano i film western e i colossal storici. Non volevo sposarmi, né avere figli, almeno fino a una certa età della mia vita.
Tutto questo non voleva dire che non avessi un sesso femminile, anche se il mio immaginario era spostato su giochi e gusti maschili sul piano estetico; né che sulla base dell’appartenenza al mio sesso non mi si assegnassero compiti tipicamente femminili come i lavori domestici, lavare i piatti, spolverare, cucire ecc. Mestieri che io vivevo come punizione e con senso di frustrazione e vittimismo.
Erano i compiti da eseguire e i ruoli da rincorrere, tradizionalmente legati al mio sesso che io rifiutavo e vivevo come condanna e espiazione per una colpa di cui non conoscevo il nome. Per riscattarmi e uscire da quei ruoli, facevo giochi maschili che davano l’illusione della libertà. Certo il femminile e il maschile, soprattutto nell’adolescenza, sono congiunti, l’incertezza sulla propria identità sessuale fa parte del processo di crescita di un adolescente. Ma questo non può mettere in questione la presenza di una corporeità data, con caratteristiche precise.
Quando Judith Butler afferma che il genere è performativo, intende dire che il genere è una costruzione linguistico-discorsiva e sociale, come per Joan Scott è una costruzione storica e quindi mutevole nello spazio e nel tempo.
Ma la costruzione del gender non può azzerare l’immanenza di un corpo dotato di caratteristiche precise. Le critiche alle teorie del gender hanno messo a nudo i rischi della scomparsa del corpo con tutte le sue differenti denotazioni, non si tratta solo di parlare di donne e della loro esclusione o discriminazione ma di affrontare tutte le differenze sessuali, etniche, razziali etc. E non si tratta solo di capire ogni tanto qual è il soggetto più debole, più discriminato, più orrorifico. Non si tratta, cioè, di creare tante appartenenze discriminate, tante piccole nazioni, da difendere contro una cultura dominante patriarcale, fallologocentrica, capitalistica. Si tratta forse di uscire dal gioco binario dominato/dominante e porre al centro la questione che la continua ricerca identitaria non fa altro che espungere un altro da sé che diventa a sua volta discriminato e oppresso. La logica binaria rientra nella logica dualistica amico/nemico in cui il volto dell’altro è il nemico assoluto da eliminare. Lo abbiamo visto in tutte le guerre combattute con le armi o con i respingimenti alle frontiere.
La logica dell’immanenza conduce allo stare, a fermarsi a guardare, da un punto di osservazione particolare, il molteplice che alberga dentro e fuori di noi, differente per ognuno di noi ma degno di essere ascoltato, percepito, visto. La categoria interpretativa, posta come unica e assoluta, divide, frantuma.
Certo, liberare l’androgino che è in noi senza sensi di colpa ma tenere ferma la barra su alcune questioni: 1) che è necessario interrogarsi sempre di quale sostanza siano i nostri sogni, i nostri desideri, e, quindi, su come sia costruito il nostro immaginario; 2) che la nostalgia della perfezione originaria o di una complementareità fusionale è già inquinata dalle origini, che, quindi, non c’è nessuna autenticità, nessuna purezza originaria o verità assoluta da ritrovare; 3) che non basta essere per la classe oppressa, per il sesso oppresso, donna, queer, omosessuale, lesbica, androgino o ermafrodito, perché le differenze si moltiplicano nell’epoca della postmodernità, definita da Rosy Braidotti «[…] come l’era della proliferazione delle differenze. Entrano in scena gli altri svalutati che costituivano il complemento speculare del soggetto moderno, la donna, l’altro definito in base all’etnia, alla razza e alla natura […].» (R. Braidotti Trasposizioni. Sull’etica nomade, Luca Sossella Editore, Roma, 2005, pp. 21-22).
Allora è sulla categoria di soggetto che bisogna interrogarsi.
Di quale soggetto stiamo parlando?
Rosy Braidotti, nel suo ultimo libro, Postumano, include soggettività non umane, esseri viventi non parlanti ma senzienti, nomadi, ibridi, non dominanti, non elitari, in divenire: «Se il potere è complesso, diffuso e produttivo, così deve essere la nostra resistenza a esso» R. Braidotti, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, DeriveApprodi, Roma 2014, p. 35).
Per questo è necessario interconnessione, l’apertura con altre soggettività e trovare i nessi, capire come ci collochiamo in un mondo globalizzato, postmoderno, come il nostro stare al mondo è iscritto all’interno di una cartografia corporea ed emotiva interconnessa sul piano spazio-temporale e geopolitico.
Uscire dal dualismo significherebbe accettare il molteplice e assumersene la responsabilità, facendo i conti con un corpo dato, costruito culturalmente e poi come tale naturalizzato.
Infine, quanta pratica dello smascheramento delle “posizioni di potere che inevitabilmente abitiamo in quanto siti della nostra identità” troviamo nell’agire politico delle nostre rappresentanti in Parlamento? Manca un pensiero politico della differenza sessuale, una elaborazione critica dei propri modelli di riferimento, un cadere continuo nel dualismo binario amico/nemico, c’è, invece, un desiderio di compiacere e di essere approvate al punto che anche la seduzione o la maternità, come ai vecchi tempi, diventano strumento di potere.
Condivido l’amara analisi di Isabella Peretti e Vittoria Tola, la lucidità di Maria Luisa Boccia o di Francesca Koch. Denunciano una povertà di pensiero che però, penso, sia in parte anche dovuto alla sempre più frammentazione e specializzazione dei saperi: da una parte ci sono le filosofe, le storiche, le scienziate, dall’altra ci sono le politiche di professione, il movimento delle donne, il movimento femminista. Una specializzazione dei saperi il cui obiettivo principale diventa la carriera, dimostrare di essere brave. E’ caduta a terra, nel fango, la passione di ricerca che animava la politica delle donne, il comprendere il mondo utilizzando tutti i saperi, in un meticciato pluridisciplinare fecondo che forniva chiavistelli per abbattere muri e aprire nuove frontiere.
Forse, come scrive Gabriella Mariotti in questo libro, bisogna ripensare al mito di Antigone, rileggere la politica e il mondo dalla sua tomba e da lì ascoltare le voci perdute della nostra vita, della nostra storia. Ascoltare le voci e le ragioni del cuore contro quelle dello Stato e nella cavità del cuore risentire la piétas perduta, accogliere non espungere, “salvare dal mare” diceva il 25 aprile la sindaca di Lampedusa Nicolini, contro le biopolitiche che governano corpi in carne e ossa, maschili e femminili, e popolazioni in fuga.
Scriveva nel 1953 Hanna Arendt, in un mondo sconvolto dalla paura del nucleare e della guerra fredda “Qui è in gioco non soltanto la libertà ma la vita, la sopravvivenza dell’umanità e forse di ogni forma di vita organica sulla terra. La questione che ne deriva rende discutibile tutta la politica; essa mette in dubbio che nelle circostanze attuali la politica sia compatibile con la conservazione della vita, e spera in cuor suo che gli uomini si ravvedano ed eliminino la politica prima che la politica elimini tutti loro.” (H. Arendt, Frammento 3a, in Che cos’è la politica, Comunità, Milano 1997p. 22).
Speranza, questa, “utopica”, obietterebbero in molti, che lascia immutata la questione, posta dall’autrice con grande lungimiranza e che oggi soprattutto diventa urgente. Con maggiore evidenza adesso la politica interessa la vita, “la nuda vita” ridotta alle sue necessità biologiche, sia che si tratti del problema del controllo della popolazione e delle nascite, del regolare la fame e la sete, gli spostamenti da un confine all’altro, la riproduzione artificiale di un feto, sia che si tratti di deciderne geneticamente la sorte. E la politica quanto più cerca di governare e controllare la vita biologica, tanto più si tecnicizza e si separa dalle forme reali che essa assume nel vivere quotidiano e dai soggetti in carne e ossa. Si tratta di una espropriazione violenta della libertà dei singoli che passa attraverso la negazione della possibilità di decidere del proprio corpo, della propria maternità e sessualità. In questo senso la riflessione di Foucault si incrocia con quella di Arendt.
“Quel che cerco, è provare a mostrare come i rapporti di potere possano passare materialmente attraverso lo spessore stesso dei corpi, senza dovere essere rimpiazzati dalle rappresentazioni dei soggetti (..) vi è una rete di bio-potere, di potere somatico ed è in quella rete che nasce la sessualità storica e culturale, all’interno della quale noi ci riconosciamo e ci perdiamo a un tempo.” (M. Foucault, I rapporti di potere passano attraverso i corpi, in “Millepiani”, 9, 1996, p. 13)
Il disamore per la politica e la sua perdita di senso per le donne, ma anche per gli uomini, hanno, oggi, a che fare con questa espropriazione del privato, di ciò che attiene alla sfera dei sentimenti e delle scelte individuali come se il destino di tutti si giocasse su un tavolo in cui il proprio essere al mondo non ha più nessuna relazione con la politica, diventata sempre più lontana.
La “pratica dell’inconscio“, disordinando tutte le categorie usate dalla cultura occidentale e dalla politica tradizionalmente intesa, tendeva alla destrutturazione delle identità, intese come prodotti storici e culturali, scavava nel profondo, nel rapporto con l’origine, con la madre, i processi di costruzione di una identità mai data per certa e aprioristicamente fondata.
Concetta Brigadeci
L’androgino tra noi
a cura di Barbara Mapelli. Scritti di B. Mapelli, Nadia Pizzuti, Alice D’Alessio, Andrea Bagni, Luisella Erlicher, Gabriella Mariotti, Francesco Tedesche, Grazia Longoni, Delia Vaccarello, Stefano Ciccone, Isabella Peretti e Vittoria Tola. Interventi di Maria Luisa Boccia, Elettra Deiana, Emma Fattorini, Valeria Fedeli, Francesca Koch, Pia Locatelli, Michela Marazano, Giovanna Martelli, Delia Murer, Marisa Nicchi, Anna Simone.
Ediesse, 2016
208 p., 13 €
Leggi “L’androgino in Parlamento?”, di Isabella Peretti (sito della Libera Università delle donne)