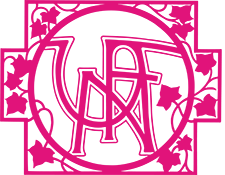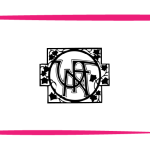Tilde Capomazza, Tivvù passione mia, Harpo, Roma 2016
Recensione di Concetta Brigadeci
Titolo questo più che mai azzeccato per un libro che racconta della passione dell’autrice per la televisione coltivata sin da giovanissima e assecondata con ostinazione e fermezza, sin da quella sera in cui disse a se stessa: “Io devo riuscirci: devo stare dall’altra parte!”. E lo affermava in un periodo, gli anni Cinquanta, in cui, come scrive Tilde, la passione per la televisione era “proprio sbagliata”. Perché
«Dire televisione voleva dire spettacolo, una parola molto equivoca all’epoca. Una giovane donna che pensasse seriamente di inserirsi in quel mondo, sembrava avere ambizioni sconvenienti».
Una scommessa non da poco per la giovane Tilde a cui, già a 23 anni, non interessava lo spettacolo fine a stesso, oggi diremmo la televisione spazzatura, ma pensava che
«[…]la cultura poteva diventare spettacolo ed essere alla portata di tantissima gente per la quale gli strumenti in uso, giornali e libri in prevalenza, non offrivano questa possibilità. Io questo l’avevo chiarissimo […] nella mia testa provavo […] a immaginare uno spettacolo culturale, qualcosa di visibile e coinvolgente, ed è quello che ho realizzato via via che ho potuto “mettere le mani in pasta».
Un’antesignana della public history, Tilde. Aveva capito a Pozzuoli, nel 1954, la forza comunicativa della TV, in quella folla di condomini che si accalcava tutti i giovedì davanti all’unica televisione posseduta da un vicino per vedere Lascia o raddoppia di Mike Bongiorno. La Tv come medium facilitatore e acceleratore di alfabetizzazione, cultura, identità.
Una passione la sua che la porta a Roma. Tilde lascia il suo lavoro di insegnante a Bergamo per entrare prima nella redazione della rivista cattolica «Impegno» e poi nelle fauci del nuovo drago che dal 3 gennaio del 1954 ammalia e rivoluziona l’Italia intera: la televisione. Una sfida, quella di Tilde, alle forme di comunicazione consuete, alla Chiesa al suo stesso cattolicesimo militante che andrà in crisi, alla Dc allora egemone. Una sfida esercitata con programmi assolutamente dirompenti per la Tv degli anni Settanta. Dopo l’esperienza nella redazione del programma televisivo Sapere, il suo Si dice donna porta sulla scena televisiva temi e problemi posti da un movimento femminista che ancora faceva paura. Così ritroviamo una giovanissima Annarita Buttafuoco che presenta in modo rigoroso e documentato Olympe de Gouges o il movimento suffragista di primo Novecento; Maria Luisa Boccia o attrici famose come Laura Betti, Monica Vitti che dialoga con una suora sul significato della vocazione religiosa.
Una televisione raccontata da Tilde in cui ciò che conta non è la seduzione della conduttrice, la nostra è sempre vestita con “gonna e camicetta”, ma i contenuti di inchiesta e di grande impatto sociale: l’aborto, il lavoro, la sessualità. Temi scottanti.
E tutto è raccontato in questa autobiografia con candore, semplicità e la freschezza ritmica di un ruscello di montagna. Non c’è enfasi, rischio della scrittura autobiografica, ma l’esperienza vissuta si mostra per quella che è stata, mossa da un’urgenza necessaria che rende le azioni di Tilde naturali, quasi ovvie e mai eroiche come invece erano.
Perché ci vuole coraggio, determinazione per portare avanti le proprie passioni e non rassegnarsi a un destino femminile già deciso. Coraggio non solo per sé ma anche per farsi carico di progetti di amiche e compagne. Come avviene con la nascita della rivista «DWF», pensata e desiderata da Annarita Buttafuoco e da Tilde sostenuta assumendosi la responsabilità della direzione, offrendo la disponibilità della propria casa per le riunioni redazionali.
E ci vuole ancora più coraggio, oggi, ad esporsi in modo così spontaneo, genuino in questa sua autobiografia bella ed esemplare per le giovani generazioni che troppo spesso abbandonano i propri sogni e rinunciano alle proprie passioni.
Leggi anche la recensione di Liliana Moro sul sito della Libera università delle donne